Che cosa è il public speaking?
Siamo arrivati all’ultimo della serie di articoli dedicati allo storytelling nel campo del Public Speaking, e mi dà un certo piacere che questo nostro percorso si chiuda proprio all’inizio dell’anno nuovo: è come un invito da qui in avanti, per chi vuole, a cimentarsi con gli esercizi e i consigli proposti.
Quest’ultimo articolo vuole ricapitolare tutto quello che ci siamo detti, per riuscire a rispondere alla fantomatica domanda: “Cos’è il public speaking?”.

Fin da subito abbiamo visto che il public speaking è una ramificazione dello storytelling, ossia dell’arte oratoria che esiste fin dall’antichità: in particolare, si occupa del riuscire a parlare a un pubblico su un argomento specifico, ed è generalmente utilizzato in ambito lavorativo durante riunioni di lavoro, brainstorming o presentazione di progetti e prodotti.
Lavoro per fasi: testo e immagini, respirazione e corpo
Il public speaking è un lavoro che si muove per fasi, dove l’esposizione pubblica è solo l’ultima parte di un processo di preparazione e rifinitura: alla base c’è il testo da esporre e la gestione del proprio corpo, nel senso di respirazione ed atteggiamento del corpo (postura, gesti delle mani etc.) per dare o meno enfasi a ciò di cui si parla.
Testo e immagini
Per il lavoro sul testo da esporre abbiamo visto che si può ed è consigliato lavorare per immagini, ossia riuscire a visualizzare le varie parti del discorso in modo da poter avere maggiore fluidità nell’esposizione: quello che potrebbe essere visto come un “cattivo esempio” di public speaking è, ad esempio, la poesia che da bambini dovevamo imparare a memoria.
Uso le virgolette nel “cattivo esempio” perché imparare le cose a memoria è un importante esercizio per la mente, che così impara a velocizzare questo importante processo di assorbimento e immagazzinamento delle informazioni; la parte “cattiva” è il cercare poi di ripetere le informazioni così come si è cercato di memorizzarle, in quanto impedisce la seconda importante fase che deve essere operata dal nostro cervello, vale a dire la rielaborazione dell’informazione che da pensiero diventa parola.
Il lavoro delle immagini serve proprio per aiutare il cervello nella fase di rielaborazione, in quanto si cerca di legare l’idea astratta ad un’immagine che possa dargli forma e ci permetta, nel caso non si riesca a trovare quelle determinate parole, ad utilizzare dei sinonimi che ci permettano comunque di esplicare l’idea e portare avanti il discorso.
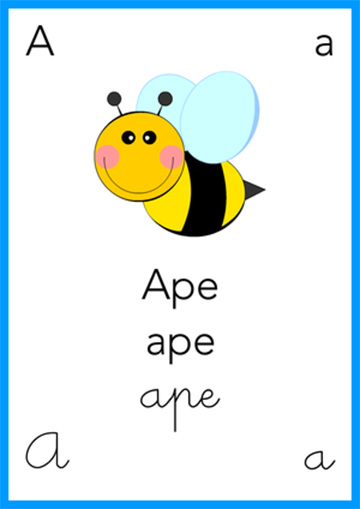
Questo lavoro in realtà ci viene insegnato ancora prima della memorizzazione: nella scuola dell’infanzia e alle elementari l’insegnamento delle prime lettere e poi delle prime parole è fatto proprio con l’utilizzo di immagini.
Corpo, respirazione, postura
Al lavoro sul testo, come già detto, va affiancato il lavoro del corpo, dove la forza del gesto o l’espressione del volto può sottolineare l’importanza di un concetto.
Un esempio particolare del rapporto tra parola e corpo è quello del Telegiornale in LIS, ossia nella lingua dei segni per i sordomuti che spesso viene trasmesso nel pomeriggio in televisione: in alcune varianti vi è solo la voce principale fuori campo con l’interprete LIS in schermo; in altri casi invece vi sono sia la giornalista che la traduttrice riprese una accanto all’altra.
In entrambi i casi, è molto interessante l’esposizione dell’interprete LIS, poiché non sono solo le sue mani a comunicare il messaggio: la bocca pronuncia determinate parole, e la stessa mimica facciale dà ulteriore peso alla notizia che sta trasmettendo.

Ovviamente nel suo caso l’interprete LIS porta all’esagerazione la gestualità e l’espressione per necessità, ma questo può diventare un interessante esercizio per la prima fase del lavoro: durante le prime esposizioni, possibilmente fatte davanti allo specchio o davanti ad una persona che vi aiuta, cercare di esagerare gestualità e mimica facciale anche per “sentire” cosa può andare bene e cosa no, in che punto diminuire o togliere la gestualità e dove invece tenerla per sottolineare maggiormente.
Passi ulteriori: ambiente, ascolto, gli altri
Continuando nella nostra ricapitolazione, vediamo gli altri aspetti che abbiamo trattato, cercando però di tenere sempre a mente un approccio “globale” e “olistico” a tutta la questione public speaking.
L’ambiente
Vi ricordere che al testo e al corpo abbiamo aggiunto un altro punto importante: l’ambiente. È importante, infatti, anche il luogo in cui viene fatto il public speaking, poiché è tramite l’equilibrio tra chi parla, lo spettatore e l’ambiente che il public speaking ha i maggiori risultati.
Un esempio palese fatto nell’articolo inerente a questo tema è stata l’aula di università, dove le regole dell’ambiente, l’atteggiamento degli studenti e quello del professore favorisce lo svolgersi della lezione.
L’ascolto
Tutto questo si basa inoltre su un altro principio, quello fondamentale del public speaking e dello storytelling in generale: l’ascolto. Senza l’ascolto non ci sarebbe modo di condividere e conoscere, e così chi parla non potrebbe comunicare la sua idea senza qualcuno che lo ascolti e un ambiente che permetta l’ascolto.
Sembra apparentemente banale ma, nonostante abbiamo due orecchie e una sola bocca, molto spesso è più difficile per noi ascoltare l’altro piuttosto che il suono della nostra voce.
Gli altri
Seguendo questo principio dell’ascolto abbiamo poi avuto modo di parlare del rapporto con i colleghi, da sempre un’incognita del lavoro in ufficio o comunque collettivo, dove riuscire a essere una squadra è fondamentale per la buona riuscita; per quanto possa sembrare non correlato, il lavoro sul public speaking può aiutare, in quanto è un lavoro che ci insegna l’ascolto, il quale può esserci su diversi livelli.

Quante volte ci basta “sentire” il modo di fare o di parlare del collega nei confronti nostri e nei confronti degli altri colleghi per sapere che gli stiamo “cordialmente” antipatici? È proprio grazie a questo ascolto che possiamo intuire come comportarci nei suoi confronti, anche relazionandoci con gli altri colleghi e con l’ambiente a favore della resa del nostro lavoro.
Resa e accettazione
Abbiamo dedicato l’ultima parte del nostro “viaggio” con la parola resa che rappresenta una dimensione forse delle più importanti: quella dell’accettazione del fallimento e dell’arrendersi.
È probabile che qualcuno si irrigidisca ancora di fronte a questa frase, anche perché è difficile, praticamente impossibile, sradicare qualcosa come il bisogno di “vittoria” nel mondo del lavoro, dove chi perde affonda nel mare degli squali. Eppure nel teamwork e nelle pratiche collaborative e condivise come tecniche quali il brainstorming, quasi mai il primo tentativo dà risultati completamente soddisfacenti. Anzi, in genere l’idea di una persona può non essere accettata dal resto del gruppo o può essere addirittura modificata per qualcosa di diverso.
Proprio come da bambini ci si metteva in gruppo per scegliere che gioco fare tutti assieme. non sempre il proprio gioco era quello scelto subito, ma ognuno aveva la possibilità di dire la sua, cosicché si stabilivano le guardie e i ladri, si iniziava la conta per capire chi stava sotto a nascondino oppure si decideva il proprio ruolo nel gruppo degli esploratori per vivere la grande avventura.
Spunti per l’esercizio
Professori di università e bambini, interpreti della lingua dei segni (LIS) e giornalisti: piccoli esempi di public speaking si trovano ovunque ogni giorno.
Ma come è possibile “allenarsi” in una “arte” come questa? Be’ un esempio è rappresentato da attività “normali”, quali ad esempio i giochi di ruolo. Se ci pensiamo un attimo, il Master dei giochi di ruolo come Dungeons&Dragons è l’esempio perfetto di storyteller: chi parla crea la storia e non solo guida i giocatori dentro la storia, ma deve anche ascoltarne le intenzioni, capirne le scelte giuste e sbagliate, muovere personaggi secondari e gestire i combattimenti. E tutto questo va fatto in un preciso ambiente stabilito dalle regole, usando solo i dadi e la parola.
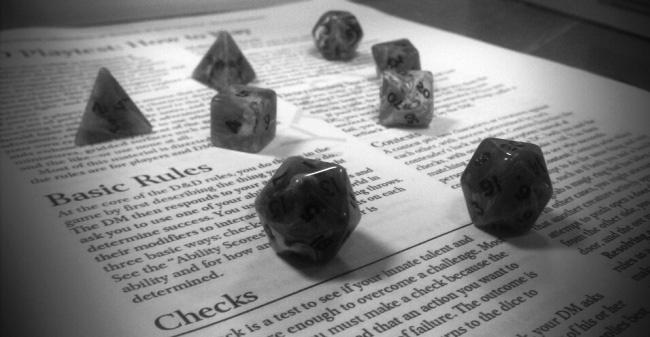
I giochi di ruolo, che ai più seri e rigidi possono apparire solo strane attività ludiche adatte per “nerd”, sono in realtà una vera e propria palestra per la mente e per la propria autostima sia per chi “guida” che per chi si fa “guidare”: si è spinti a usare il linguaggio giusto in determinati momenti, ad ascoltare attentamente tutto quello che succede, a usare immagini nella propria testa per riuscire a descrivere l’ambiente, a creare un ambiente sicuro dove tutti possano esprimersi in tranquillità.
Non è in fondo uno degli obiettivi dell’Agilità anche quello di creare ambienti di lavoro dove ognuno si senta sicuro di potersi esprimere e di poter lavorare al meglio delle proprie possibilità?
Conclusioni
Siamo arrivati alla fine di questo percorso in cui ho cercato raccontare qualcosa sullo storytelling, l’attività di cui mi occupo. Mi ha fatto davvero piacere parlare di questi argomenti su uno spazio come MokaByte che tratta in genere di tematiche più tecniche o manageriali. Spero che l’approccio “obliquo” a certi aspetti sia stata l’occasione per i lettori di confrontarsi con qualcosa che magari ha suscitato in loro qualche interrogativo e qualche interesse.
Ringrazio chi ha seguito questa serie, e spero che ciò che ho scritto possa esservi utile per il vostro lavoro, nell’ottica di migliorare la comunicazione tra e con le persone, e di creare ambienti più collaborativi e condivisi.
Martina Rigoni è laureata in Performing Arts. Si occupa di "storie" nell'accezione più ampia possibile esplorando nuovi metodi di narrazione orale, anche attraverso il gioco ed il videogioco.
Dal 2011 al 2015 ha lavorato presso la Compagnia di Storytelling "Raccontamiunastoria". Ha rappresentato la Federazione Italiana Storytelling alla Conferenza FEST (Federazione Europea Storytelling) che si è svolta a Kea in Grecia nel 2015. Ha contribuito all'organizzazione di numerose edizioni del Festival Internazionale di Storytelling svoltesi a Roma e Bolzano, e ha partecipato a svariati altri eventi tra cui "Beyond The Border, Festival di Storytelling in Galles".


